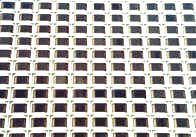 come noi lo immaginiamo nella nostra testa,
non si trova certo in Malaysia, forse lo troveremo in Cambogia, in Laos o in Birmania, ma
non certo qui, dove c'è un Oriente moderno, un Oriente che ci fa "inorridire" e
ci fa riflettere su dove diavolo siamo capitati.
come noi lo immaginiamo nella nostra testa,
non si trova certo in Malaysia, forse lo troveremo in Cambogia, in Laos o in Birmania, ma
non certo qui, dove c'è un Oriente moderno, un Oriente che ci fa "inorridire" e
ci fa riflettere su dove diavolo siamo capitati.
Isola di Penang
Il viaggio per raggiungere l’isola
di Penang è durato cinque ore, non abbiamo preso il ferry che la collega alla terraferma
per ventiquattro ore al giorno, ma il ponte costruito nel 1985, che con i suoi tredici
chilometri e mezzo è il più lungo del Sud Est Asiatico ed il terzo al mondo per
lunghezza. A causa dell’alto prezzo del pedaggio la gente preferisce prendere il
traghetto che arriva direttamente nel cuore della città. Quando siamo arrivati nella
vecchia Georgetown le mie impressioni sono cambiate, le vie erano male illuminata da
lampioni che emanavano una fioca luce dal colore giallo ed il quadrilatero formato da
Lebuh Chulia, Lebuh Pantai, Lebuh Pitt e Lebuh Light era come un’enclave che,
nonostante il passare del tempo, aveva conservato tutto il suo fascino e la sua vecchia
anima. Era come se stessi facendo un viaggio all’indietro nel tempo e che qui si
mescolassero culture e tradizioni diversissime tra loro: case basse e palazzi in stile
Vittoriano, vie con le tradizionali botteghe a due piani gestite da cinesi, insegne
misteriose, chiese cattoliche, templi Indù e Taoisti, profumi d’incenso, di curry e
sentori d’India, odori di cibi diversissimi tra loro, donne velate e uomini con
tuniche e vestiti vaporosi. Nello stesso tempo mi sembrava di essere a Goa, a Calcuttao a Nanchino, insomma tutto l’opposto, che il
ritrovarmi in un Paese a maggioranza mussulmana.
a Nanchino, insomma tutto l’opposto, che il
ritrovarmi in un Paese a maggioranza mussulmana.
Sono riuscito a cambiare qualche dollaro,
così ho messo in tasca i miei primi Ringgit e
ho trovato una stanza al “D Budget Hostel”, al n. 9 di Lebuh Gereja (chiamata
anche Church Street), un piccolo hotel senza troppe pretese. Ho abbandonato in camera lo
zaino e sono andato a piedi verso il cuore della Georgetown storica: verso la chiesa di
St. George, il più vecchio tempio anglicano del Sud Est Asiatico, ma soprattutto verso
l’Esplanade, un grande spazio erboso (utilizzato in occasione di feste come il
Capodanno Cinese e di Chap Goh Mei), contornato da bei palazzi in stile coloniale come il
Municipio, la Corte Suprema e la biblioteca della città. Mi trovo vicino al forte
Cornwallis, il luogo che ricorda l’arrivo di Francis Light che sbarcò
sull’isola nel 1786 e che ne prese possesso per conto della Compagnia delle Indie
Orientali. Light chiamò la capitale Georgetown, in onore del Re della Gran Bretagna
Giorgio III. Prima dell’arrivo degli inglesi l’isola era pressoché disabitata,
Light offrì protezione al sultano del Kedah che come contropartita la cedette agli
inglesi. Costoro avevano un assoluto bisogno di una base d’appoggio navale nel golfo
del Bengala (come rifugio durante il monsone di nord est), di un punto
d’approvvigionamento per le navi della Compagnia in rotta verso la Cina (impegnate
nel commercio del tè, dell’oppio e delle spezie), e di una base per ipotizzare
un’eventuale futura supremazia nelle acque del Sud Est Asiatico. Le fortune
dell’isola terminarono nel 1832 quando Singapore si sostituì a Penang come centro
dei traffici inglesi e questa divenne la capitale delle “Colonie nello Stretto”.
L’isola crebbe ancora in importanza attorno al 1850 con la scoperta dei giacimenti di
stagno nella vicina terraferma e grazie al boom della gomma d’inizio secolo.
al boom della gomma d’inizio secolo.
Oggi l’isola costituisce lo Stato di Penang, è retta da un governatore nominato dal re della Malaysia, ed è uno dei tredici stati della confederazione malese. L’isola non ha solo un passato coloniale: la zona del porto, i negozi e le attività commerciali sono nelle mani dei cinesi. Assieme agli inglesi arrivarono anche i “Sepoys”, gli indiani al servizio degli eserciti europei e i commercianti indiani, che come i cinesi, non abbandonarono più l’isola. Ancora oggi quartieri come “Little India” o “Chinatown”, mantengono inalterato un fascino che ricorda i legami con il passato.
Vicino all’Esplanade c’erano tante bancarelle illuminate come alberi di natale che vendevano pesce, crostacei, frutta e bevande colorate: grandi cartelli scritti a mano indicavano che qui si servivano laksa (zuppa con spaghettini in brodo in salsa di cocco), nasi goreng (riso fritto), ketupat (riso bollito avvolto in foglie dell’albero del cocco), satay (spiedini di carne), rendang (carne al curry), rojak (insalata di frutta e verdure) e gulu melaka (dolce di sago affogato nel latte di cocco), tutti termini che avrei imparato nei giorni successivi. Ho ordinato un gran piatto di molluschi, riso con gamberetti al curry e un impasto d’uova di pesce. A tavola c’è chi mangia con le mani ed il rutto è libero, mi guardo attorno e mi stupisco per questo crogiolo di razze, per i tanti visi con gli occhi a mandorla, per i mussulmani dalla pelle scura, per volti che sembrano provenire dall’India del Sud o dallo Siri Lanka. Dopo cena sono tornato in camera e mi sono addormentato.
Alla mattina sono andato
in Lebuh Pantai, una via con piccoli uffici cambiavalute gestiti da Indiani e banche
collocate in edifici in stile Vittoriano. Gli interni sono asettici e pieni di luce, le
impiegate indossano impeccabili tailleur colore panna e lavorano in un ambiente simile  a quello della “City” di Londra. Solo quando
ti passa accanto una donna velata (poche per la verità), ti ricordi dove ti trovi. Ho
iniziato a camminare per la zona del porto, da dove partono i traghetti per Butterworth,
ci sono tanti cartelli con gli ideogrammi e nella lingua malese ed il caldo è devastante.
Dopo avere visitato il tempio indiano di “Sri Mariamman”, famoso per le
elaborate sculture che formano un gopura
all’entrata (una torre piramidale con Dei e animali), mi sono rifugiato in un tempio
cinese, apprezzato per gli efficienti ventilatori a pale. Sono poi stato alla moschea
“Kapitan Kiling” costruita alla fine del 1700 in stile indiano, ha un singolare
minareto di colore giallo che ricorda una torre campanaria. L’integrazione religiosa
sembra totale, templi indù e cinesi, chiese cattoliche e moschee sembrano convivere in
perfetta simbiosi.
a quello della “City” di Londra. Solo quando
ti passa accanto una donna velata (poche per la verità), ti ricordi dove ti trovi. Ho
iniziato a camminare per la zona del porto, da dove partono i traghetti per Butterworth,
ci sono tanti cartelli con gli ideogrammi e nella lingua malese ed il caldo è devastante.
Dopo avere visitato il tempio indiano di “Sri Mariamman”, famoso per le
elaborate sculture che formano un gopura
all’entrata (una torre piramidale con Dei e animali), mi sono rifugiato in un tempio
cinese, apprezzato per gli efficienti ventilatori a pale. Sono poi stato alla moschea
“Kapitan Kiling” costruita alla fine del 1700 in stile indiano, ha un singolare
minareto di colore giallo che ricorda una torre campanaria. L’integrazione religiosa
sembra totale, templi indù e cinesi, chiese cattoliche e moschee sembrano convivere in
perfetta simbiosi.
A piedi mi sono diretto verso il Komitar, un centro commerciale visibile da ogni
parte della città, costruito ai piedi di un obbrobrioso grattacielo di sessantacinque
piani a forma circolare, con negozi alla moda e piccole botteghe. All’interno non
mancano i “Pizza Hut” o i “Mc Donald’s”, ma c’è sempre un
qualche cosa, tra negozi di bigiotteria femminile, d’oreficeria e di DVD falsi, che
ti ricorda “ancora” che qui sei in
Asia. Ho camminato per la Jalan Sultan Ahmad Shah, una lunga via che costeggia il mare e
ho raggiunto un altro centro commerciale chiamato “Gurney Plaza”, con boutique griffate e bei
negozi. Nulla, a parte i volti della gente, ti ricorda che  sei nel Sud Est Asiatico. Non finisco mai
di stupirmi per tutta questa opulenza, per i vestiti che più che coprire il corpo
femminile sembrano fatti apposta per scoprirlo, per la mancanza assoluta di donne con la
testa avvolta in foulard e per l’utilizzo smodato di telefoni cellulari. Il
“target” è adolescenziale, imperano spalle nude, calzoni alle ginocchia, jeans
attillati, timide minigonne, “make up” e portamenti provocanti, che ti
ingolosiscono, come caramelle da scartare.
sei nel Sud Est Asiatico. Non finisco mai
di stupirmi per tutta questa opulenza, per i vestiti che più che coprire il corpo
femminile sembrano fatti apposta per scoprirlo, per la mancanza assoluta di donne con la
testa avvolta in foulard e per l’utilizzo smodato di telefoni cellulari. Il
“target” è adolescenziale, imperano spalle nude, calzoni alle ginocchia, jeans
attillati, timide minigonne, “make up” e portamenti provocanti, che ti
ingolosiscono, come caramelle da scartare.
La mia idea di un Paese popolato da donne velate e vestite con abiti formali (i Mussulmani rappresentano pur sempre la maggioranza della popolazione, anche se la zona maggiormente islamica è la costa orientale) deriva da un’idea rafforzatasi nella mia testa, dopo la tragedia delle Torri Gemelle dell’11 settembre, di un Occidente buono e sviluppato, “Paladino e rivelatore della Verità” e di un Oriente Mussulmano barbaro, retrogrado e sottosviluppato. Mi ha colpito la “globalizzazione” dell’universo giovanile: l’abbigliamento, il modo di imporre il proprio “look”, i ritrovi e i gusti dei giovani di Georgetown sono gli stessi dei coetanei di Bangkok, di Taipei, di Milano o di Londra. In quest’asettico centro commerciale, ho notato una tale assenza d’identità ed una totale “uniformità globalizzata” che mi hanno fatto riflettere e rabbrividire.
1 2 3 4 5 | Diari Index